Mentre nel passato per ‘qualità della vita’ si intendeva lo sforzo per garantire pari opportunità anche a coloro che subivano una evidente emarginazione a causa di una malattia, di una debolezza economica, di una disabilità, oggi il significato che viene dato è fortemente sbilanciato nella considerazione della capacità di una persona di poter produrre, consumare e godere del pieno benessere fisico.
Si stabiliscono dunque via via degli standard di qualità da cui si fa dipendere la qualifica di ‘persona’.
In Medline, la banca dati mondiale degli articoli scientifici, il numero dei lavori che contengono il termine “qualità della vita” è passato da 12 nel 1970 a oltre 10.000 nel 2001.
A fronte di tali nuove interpretazioni etiche, il pericolo che si corre è nel ritenere disponibile ogni vita umana che non corrisponda a determinati standard, per cui se un individuo perde la sua capacità di consumo perde anche il diritto ad esistere.
 Il biologo Jacques Testart, diventato famoso grazie ad Amadine, la prima bambina francese concepita in provetta, oggi, a quasi settanta anni, scrive libri contro quello che definisce “eugenismo democratico”, che si è ripulito da untuosità razziste ed ora invoca il diritto di avere figli sani, di vivere bene e avere una morte ‘dignitosa’.
Il biologo Jacques Testart, diventato famoso grazie ad Amadine, la prima bambina francese concepita in provetta, oggi, a quasi settanta anni, scrive libri contro quello che definisce “eugenismo democratico”, che si è ripulito da untuosità razziste ed ora invoca il diritto di avere figli sani, di vivere bene e avere una morte ‘dignitosa’.
Questa nuova eugenetica politicamente corretta usa come arma la paura che l’uomo ha del dolore e della malattia.
Come scrive Marina Corradi sull’Avvenire del 26 settembre, riferendosi al caso Welby, “La logica del caso umano, della faccia di un uomo sofferente portata come argomento decisivo e ispiratore di una legge, è potente. L’immagine di quei testimoni è  eloquentissima e porta anche gli avversari ad abbassare la voce, perché quel dolore, che è autentico, facilmente zittisce ogni obiezione. La faccia di un uomo che paralizzato nel suo letto chiede di morire ha un impatto potente, più di mille ragionamenti.”
eloquentissima e porta anche gli avversari ad abbassare la voce, perché quel dolore, che è autentico, facilmente zittisce ogni obiezione. La faccia di un uomo che paralizzato nel suo letto chiede di morire ha un impatto potente, più di mille ragionamenti.”
Giovanni Battista Guizzetti è un medico che da 25 anni assiste coloro che sono sospesi in una condizione di confine: i malati terminali, quelli non guaribili e, quelli in stato vegetativo.
Guizzetti ha appena pubblicato un libro “Terri Schiavo e l’umano nascosto, la medicina tecnologica e lo stato vegetativo” con cui, attraverso la testimonianza dell’impegno nel Centro Don Orione di Bergamo, disegna la situazione di quelle persone che dovrebbero far ricorso al testamento biologico. A lui poniamo alcune domande.
Nella lettera indirizzata al Presidente Napolitano, Piergiorgio Welby espresse il desiderio che ai cittadini italiani fosse data la stessa opportunità concessa a quelli svizzeri, belgi, olandesi. Decidere delle propria morte è dunque una opportunità?
Quando sento parlare di diritto alla morte, di diritto a decidere di porre fine alla propria e all’altrui vita, proprio non capisco, sono preso da un grande sconcerto. Perché avere a disposizione uno specialista che ti ammazza dovrebbe essere un’opportunità o un diritto? Vede io faccio il medico da 25 anni. Per una mia personale tensione ho sempre cercato di occuparmi delle condizioni di confine: dei malati terminali, di quelli non guaribili e, da ultimo, delle persone in stato vegetativo. Le posso assicurare che mai, ripeto mai, mi è stata fatta una richiesta di eutanasia.
Le dico questo perché penso che sia in atto una campagna mediatica che fa apparire le problematiche sollevate, quelle dell’eutanasia e delle direttive anticipate, come una urgenza che nasce dall’opinione pubblica.
Io sono assolutamente certo che è vero il contrario: una ristretta elite di intellettuali ha deciso di ingaggiare questa battaglia e per sostenerla la fanno apparire una sorta di richiesta popolare. Il timore vero della gente, e guardi che io ne incontro molte di persone durante la mia giornata, è quello di vivere l’abbandono terapeutico, di essere lasciati soli con un dolore non controllato, di non trovare più chi accolga la loro domanda di cura perché ormai si trovino al di là di quanto i protocolli prescrivono. Non sto dicendo che non esista il problema, ma non dobbiamo cadere nella trappola tesa da alcuni ‘opinion leader’ e da alcuni circoli culturali che lo vogliono trasformare in una vera e propria emergenza nazionale.
In realtà sono convinto che l’unica fretta che costoro hanno è che si affermi definitivamente una cultura che fa dell’utilitarismo e dell’individualismo i suoi fondamenti, avendo come scopo la liquidazione definitiva di una secolare storia di umanesimo cristiano che ha fatto della compassione e della condivisione i suoi caratteri qualificanti. Mi vengono in questo momento in mente le grandi figure del secolo scorso: il beato Cottolengo, don Gnocchi, S. Luigi Orione e madre Teresa di Calcutta che si sono letteralmente fatti carico del bisogno incontrato.
Che rapporto corre fra testamento biologico e eutanasia?
Penso che mai nel nostro Paese potrà affermarsi una legislazione sull’eutanasia come quella esistente in Olanda, dove per vivere occorre una sorta di certificazione di qualità, o come quella del suicidio assistito esistente in Svizzera. Allora le direttive anticipate o testamento biologico rischiano di diventare l’escamotage e il battistrada per introdurre anche da noi l’eutanasia.
Anche in questo caso una campagna di stampa abilmente orchestrata ha fatto diventare la questione una vera e propria urgenza. Si è creato un nuovo bisogno primario: la difesa del cittadino dall’onnipotenza di una classe medica che, perso ogni senso della misura, si vuole continuare ad accanire con terapie disumane su dei morenti. Ma è davvero così?
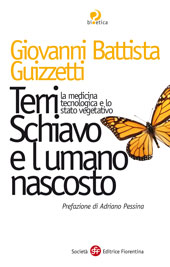 Nessuno, nessun medico e neanche la stessa Chiesa cattolica, oggi più riconosce le liceità dell’accanimento terapeutico, delle terapia sproporzionate. Il problema è che con le direttive anticipate anche la semplice idratazione può diventare una sorta di accanimento. Si induce una paura collettiva per ottenere alla fine ciò che non sono riusciti ad ottenere in altro modo. Si tenga conto tra l’altro del fatto che la dove le direttive anticipate esistono sono scarsamente utilizzate.
Nessuno, nessun medico e neanche la stessa Chiesa cattolica, oggi più riconosce le liceità dell’accanimento terapeutico, delle terapia sproporzionate. Il problema è che con le direttive anticipate anche la semplice idratazione può diventare una sorta di accanimento. Si induce una paura collettiva per ottenere alla fine ciò che non sono riusciti ad ottenere in altro modo. Si tenga conto tra l’altro del fatto che la dove le direttive anticipate esistono sono scarsamente utilizzate.
Esiste una eutanasia attiva ed una passiva?
Esiste una differenza nella prassi, non nell’intenzione. L’eutanasia attiva è un atto deliberato, attivo, che attraverso la somministrazione di una sostanza letale porta alla morte il paziente.
L’eutanasia passiva è la colpevole omissione non di un atto straordinario, ma ordinario (esempio la mancata somministrazione di acqua) che porta alla morte l’individuo. La sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione che causò la morte di Terri Schiavo è un esempio di eutanasia passiva. Vale la pena precisare e riaffermare che la sospensione della cura non sempre si configura come un atto eutanasico. Infatti quando le cure che sto erogando sono sproporzionate per la difficoltà del loro impiego e per la sofferenza provocata in chi le subisce o per lo scopo che vogliono ottenere, ad esempio le tecniche rianimatorie in un paziente neoplastico in fase terminale, la loro sospensione è da ritenersi assolutamente legittima, il loro proseguimento configura infatti quello che viene definito accanimento terapeutico.
Sempre Welby affermava che “per il modo in cui le nostre possibilità tecniche ci mantengono in vita, verrà un giorno che dai centri di rianimazione usciranno schiere di morti-viventi che finiranno a vegetare per anni. Lei che da anni assiste i pazienti in stato vegetativo pensa che siano vittime di un accanimento terapeutico?
Una cara amica, un medico che lavora nell’ U.O. di Terapia Intensiva di un grande ospedale del nord Italia un giorno mi ha chiesto: ‘Ma se tu fossi al mio posto, di fronte ad un malato che sai per certo che se lo salverai piomberà in uno stato vegetativo, cosa faresti? Proseguiresti i trattamenti rianimatori?’ È veramente difficile la definizione del limite terapeutico. Certo che ci sono condizioni in cui chiaramente questo limite viene superato che so quando si defibrilla una persona per dieci, venti volte, ma quando ci giunge in pronto soccorso un adolescente vittima di un grave trauma cranico, come fai a tavolino a definire questo limite? come fai a decidere se vale o non vale la pena impegnarci per salvare la sua vita, come si fa a essere certi della sua guarigione completa o della sua guarigione con esiti più o meno gravi?
L’errore prognostico è sempre lì pronto a tenderci le sue trappole. L’errore amplificato dalla stanchezza o da una involontaria distrazione, da un’analisi che non ha considerato tutti i fattori in gioco, da una nostra impostazione culturale o da un nostro personale giudizio sulla vita. Ho ben presente il caso di quell’ amico giunto al pronto soccorso per un infarto a cui, molto incautamente, un medico aveva pronosticato un futuro da ‘alberino di Natale’ e che oggi invece ha ripreso a lavorare, guida la macchina e conduce una felice vita familiare.
‘Casi anedottici’ si dice come per sterilizzare la categoria della possibilità, del miracolo. Ma se quel ‘caso anedottico’ fosse stato tuo figlio o tua figlia, tua moglie o tuo marito, tuo padre o tua madre cosa avresti fatto, cosa avresti detto?
Se un medico non riesce a guarire il paziente, non riuscendo a riportarlo nella condizione precedente la malattia, ha fallito?
A un paziente che giunge in un reparto di terapia intensiva si possono aprire tre scenari : la sopravvivenza con un completo o comunque accettabile recupero della funzionalità, l’indebito prolungamento del processo del morire, bloccato nel suo compiersi dalle tecniche rianimatorie (accanimento terapeutico) o, infine, l’evoluzione verso una condizione di disabilità più o meno severa che nel suo livello più grave configura lo stato vegetativo. Basta avere come scopo il solo mantenimento in vita per iniziare e mantenere un trattamento rianimatorio od occorre un previo giudizio di qualità sull’esito del nostro intervento? Il nostro agire trarrebbe legittimità solo da un successo globale? Un esito rappresentato da una più o meno grave compromissione dello stato di coscienza sarebbe comunque da considerarsi un fallimento da evitare in qualunque modo, anche con la morte del soggetto? Non penso che il successo di un intervento medico sia definito dal recupero totale.
Se la guarigione completa fosse lo scopo del nostro agire e il criterio per stabilirne la bontà gran parte dei nostri interventi non avrebbe senso. Conosco molte persone che sono rimaste in vita, anche con deficit funzionali gravi, che sono felici di esser ancora vivi, che hanno saputo ricostruire un esistenza assolutamente dignitosa a partire da quel poco o tanto che è rimasto funzionalmente integro.
I suoi pazienti le hanno mai chiesto di morire?
Non voglio più chiamare coloro che assito pazienti, non li considero dei malati, ma piuttosto dei disabili, dei gravissimi disabili. Nel libro che ho scritto dedico un capitolo intero a questo aspetto perché apre delle prospettive completamente differente nel percorso di presa in carico dello stato vegetativo. Ovviamente le persone di cui mi prendo attualmente cura non comunicando non mi hanno mai potuto chiedermi di lasciarli morire.
Ma in questi dieci anni nessuno dei loro parenti mi ha mai fatto una tale richiesta perché se hai la possibilità di sperimentare una condivisione, un sostegno anche se vivi una condizione di grave fatica come è lo stato vegetativo, questa condizione diventa meno pesante da portare e lo sguardo che porti su chi ancora ami è diverso , non so come dire, ma sai accettarlo ed amarlo anche in quello stato.
Come considera quello che una certa corrente di pensiero sostiene, ossia che una vita senza qualità non è più vita?
Tutti oggi più o meno siamo vittime di una concezione utilitaristica della vita per cui questa vale in relazione alla capacità di godimento che ti dà. Se sei un disabile, sei malato, se la tua condizione non ti consente di godere appieno di quanto la società ti offre in termini di piacere automaticamente la tua vita vale di meno, fino a non valete più nulla se di tutte queste cose non sei capace di godere. Ma è veramente questo il senso del nostro vivere? Se fosse così tre quarti dell’umanità non sarebbe degno di vita o, come si dice oggi, non sarebbero delle persone.
Il portavoce Care presso il Comitato ristretto sull’etica medica della Camera dei Lord  (1994) ha detto: “i disabili sono generalmente più soddisfatti della loro vita di quanto individui fisicamente abili si aspetterebbero di essere se soffrissero della stessa menomazione. La persona sana non opera le medesime scelte della persona malata”. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo l’individuo è riconosciuto oggetto di diritti per come è, senza alcun riferimento a qualsiasi elemento che attenga alla qualità della sua vita, è titolare di diritti per il fatto stesso di esistere.
(1994) ha detto: “i disabili sono generalmente più soddisfatti della loro vita di quanto individui fisicamente abili si aspetterebbero di essere se soffrissero della stessa menomazione. La persona sana non opera le medesime scelte della persona malata”. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo l’individuo è riconosciuto oggetto di diritti per come è, senza alcun riferimento a qualsiasi elemento che attenga alla qualità della sua vita, è titolare di diritti per il fatto stesso di esistere.
Nello stesso ordinamento giuridico quindi non si da alcun rilievo alle qualità contingentemente presenti in quel soggetto per riconoscerne la sacralità e l’inviolabilità. L’introduzione del concetto di ‘vita degna di esser vissuta’ muta radicalmente il modo di concepire le relazioni. Alla base della relazione che io instauro con te, chiunque tu sia, qualunque sia la condizione nella quale ti trovi, non c’è più una gratuità, che è una capacità di accoglienza della tua persona e di condivisione del bisogno di cui puoi essere portatore, ma un preventivo giudizio sulla tua capacità di mostrare caratteristiche particolari che possano andarmi bene.
Oggi si preferisce coniare nuovi termini, per esempio “persona” prende il posto di “essere umano” e “prodotto del concepimento” sostituisce “embrione”. A cosa è dovuta questa operazione di lifting sostantivale?
Se non partiamo dall’idea che ogni individuo è persona semplicemente perché appartiene alla specie umana, se pensiamo che persona sia un titolo di merito che si acquista ad un certo punto della vita o che si perde in certe condizioni perché non abbiamo più una qualità, una caratteristica o da una funzione, apriamo inevitabilmente la strada ad una nuova tragica antropologia che ha come esito finale la disponibilità di ogni vita umana che non corrisponda a determinati standard.
Questo è anche tragicamente testimoniato dalla storia del secolo scorso quando il criterio della razza o dell’appartenenza ad un apparato o anche semplicemente il portare gli occhiali, sapere di storia o di filosofia, o possedere un Bibbia erano motivi sufficienti per la tua eliminazione.
È in atto soprattutto nelle nostre società il tentativo di imporre questa nuova antropologia, che non è più funzionale alla ricerca di un significato che sia risposta agli interrogativi che ci costituiscono, ma funzionale ad un potere. Fondamentalmente ad un potere economico che usa dell’uomo. Per cui tu vali nella misura in cui puoi produrre e sai consumare. Ecco se tu non produci e non consumi ti sei giocato il diritto ad esistere, non sei appunto una persona. È triste, ma è così. Tutto ciò è cominciato quando l’uomo ha deciso di far fuori la ricerca del significato totale di sé.